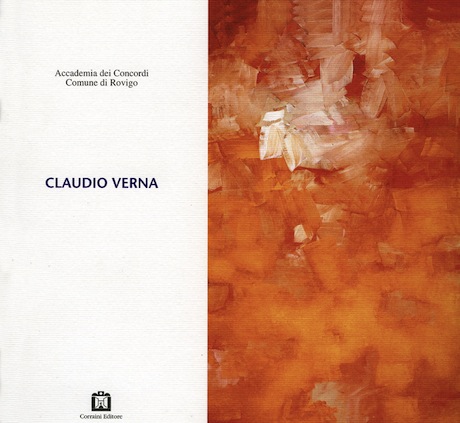 Il Cromonauta, “Art e Dossier” n. 135, Firenze, giugno 1998; e in catalogo personale Accademia dei Concordi, Rovigo, ottobre 1998
Il Cromonauta, “Art e Dossier” n. 135, Firenze, giugno 1998; e in catalogo personale Accademia dei Concordi, Rovigo, ottobre 1998
Nei dintorni di Spoleto, a Rapicciano, un piccolo borgo umbro dominato da una torre trecentesca, vive Claudio Verna. L’artista abruzzese di nascita, vissuto a Firenze e a Roma, ha scelto da alcuni anni di lavorare lì, in una grande casa secentesca, dove lo studio, all’ultimo piano, domina un paesaggio dolce e mosso dal vento; i cambiamenti di colore sono repentini, folate si posano come pennellate sull’erba e sul cielo, sulle colline e sui mattoni antichi stendendo mille sfumature di verdi, azzurri e ocra. È un luogo in cui la natura crea in continuazione tavolozze inedite, e dove il colore domina e costruisce: una “pittura della natura” un continuo sovrapporsi di toni e mezzitoni scandisce l’ininterrotta metamorfosi di questo luogo, il posto ideale per un artista che della “natura della pittura” – intesa come dominio del colore – ha fatto il centro della propria ricerca.
Artista vitale e ostinato, Verna non si è mai sottratto al confronto con le dinamiche dell’arte e della critica contemporanee, anche quando la pittura era ritenuta «antiquariato», e la sua ricerca è stata scandita lungo il corso di quarant’anni da dibattiti e colloqui con artisti e critici, da interventi e scritti, contributi in cui spicca lucida la tensione a una pittura che si sgancia dalla rappresentazione per giungere a una pura stesura cromatica, al trionfo del colore; colore che, nel corso degli anni, è stato lasciato da Verna libero di esplodere, oppure ingabbiato nella progettualità e piegato a costruire griglie geometriche, per tornare poi, nel corso degli ultimi vent’anni, a dominare, seppure domato, sulle tele e sulle carte.
La pittura di Verna si inserisce in un dibattito nato almeno un secolo fa; un dibattito che ha lasciato capolavori fatti di filamenti di colore, di macchie che costruiscono, dì aloni che vogliono evocare aure ed emozioni; una storia che ha inizio con quei covoni di Monet che alla fine del secolo scorso tanto sconvolsero un giovane moscovita, Vasilj Kandinski, e che nel nostro secolo ha originato l’esplosione dell’action painting e la riflessione che ha portato alla purezza dei monocromi, magri e opachi, di Rothko.
Allontanarsi da qualsiasi riferimento reale, sopprimere il racconto, lasciare il colore libero di vivere la propria autonoma esistenza e la capacità di suggerire emozioni e provocare nuove sensazioni; è la pittura di solo colore, dove il quadro diventa evocativo (una “madeleine” proustiana che sommuove ricordi e sensazioni perdute), e puro suono scaturito da accordi o disarmonie casuali o ricercate: una sinestesia dell’anima, che risveglia realtà più profonde di quelle immediatamente riconoscibili.
Una storia colorata
Questa storia del colore in libertà è raccontata da Verna con un’efficace sintesi, dove un arcobaleno unisce il lavoro di Monet, di cui sottolinea «l’accanimento sulla specificità dei procedimenti percettivi», Matisse che «con le carte dipinte giunse a decantare completamente la forma “disegnando con le forbici, tagliando a vivo nel colore”, Van Gogh «che disegnava con il colore», Cézanne «che costruiva con il colore», gli espressionisti tedeschi «che forzavano il colore (sia pure con declinazioni letterarie) fino a fargli stravolgere lo schema spaziale preordinato», gli artisti dell’action painting «che al colore hanno recuperato parte almeno della sua autonomia e della sua virtualità», Malevic «che proponeva un nuovo alfabeto del colore, con leggi sue proprie, perché diventasse una unità autonoma, nell’ambito di un sistema in cui la teoria fosse complementare all’esperienza», fino a Nicholas de Staёl, a cui Verna dedica nel 1987 un quadro omaggio, II muro degli uccelli, nato da una frase dell’artista francese («La pittura è un muro, ma ci volano dentro tutti gli uccelli del mondo»). Sulla tela si raccolgono canti fatti di colori, una lirica della geometria, quando la geometria diviene poesia.
Il suono dei colori
E, nel lavoro di Verna, il colore ha conosciuto ogni declinazione possibile: enfatico, prorompente, steso con pennellate a virgola, nei primi dipinti informali dove dominano la gestualità e la spontaneità, un’emotività non controllata, baldanzosa e vivace; quella stessa che viene poi imbrigliata e domata in un momento di pura progettualità, in cui il colore diviene segno controllato: rimane della vivacità iniziale un’eco nei bordi sfrangiati, un debordamento di toni lungo i segmenti rettilinei; e poi, dalla fine degli anni Settanta, il colore – che ora conosce il filtro del controllo – ritorna a tessere sulla tela delle felici esplosioni di emozioni. Permane l’energia dell’esecuzione, la sicurezza del gesto, mai violento, ma lento: ogni dipinto di Verna ha un lungo processo esecutivo e strati di colore stesi e raschiati depositano le loro tracce sulla tela o sulla carta: sono tessuti fatti di mille fili di oli e pastelli, intrecci che saturano i supporti. Eppure, un equilibrio sottile pervade ogni lavoro, dove il rigore e l’emozione si bilanciano a vicenda: il rigore giunge opportuno a frenare l’emozione che deborda nell’Ultima alba oscura o in Oltre la soglia; oppure viene spezzato dal bordo sfrangiato nel dipinto Lo scuro, dove il colore corregge e muta in ovale la troppo rigida perfezione del cerchio blu notte. L’opera si ferma quando viene a crearsi un’armonia fatta di equilibri cromatici – come in Figure accese – , di sfrangiamene sottili, di bordi filamentosi, quando la stesura larga e pastosa del l’ultimo strato trae da sparse note (tutte ormai sommerse in un succedersi di strati) una melodia continua, come in Corvi in pattuglia o nella satura Topografia minima dove una solarità accecante viene raccolta e moderata dal nucleo centrale fatto di una sinfonia di bianchi e grigi. E solo allora, alla line, quando le mille stesure depositano ognuna un cenno colorato del loro passaggio, la tela o la carta lievitano della leggerezza dei fragili segni di Licini, della gioiosità di Morisse, della forza di Staёl; e solo allora, alla fine – così racconta Verna – ricompare uno stato d’animo (un “interrogativo arrogante”, un “processo dubbioso”, un “elogio dell’ombra”), o l’atmosfera di una stagione (“il clamore dell’inverno”, “l’agonia del verde”), il ricordo di una frase, di una storia, di una visio ne (la tenda di Gengis Khan”, gli “edifici fragili”, “il lago dei suoni”, “la notte di San Silvestro”, “l’agonia della sera”: tutti titoli di opere di Verna). Suono, colore, ricordo si fondono in una solare e gioiosa sinestesia dell’anima.

