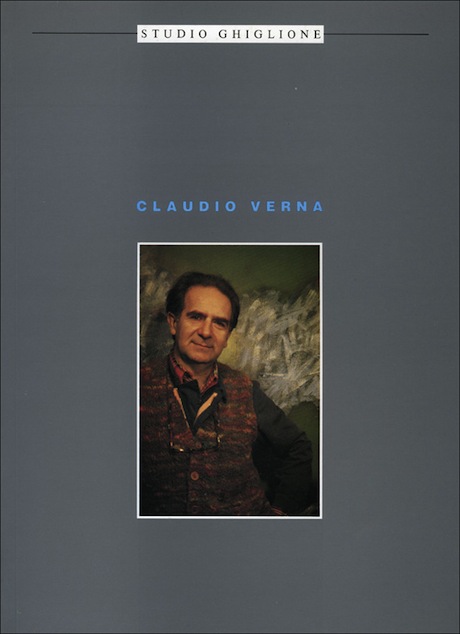 Claudio Verna, La notte di S. Silvestro, catalogo personale Studio Ghiglione, Genova, febbraio 1987
Claudio Verna, La notte di S. Silvestro, catalogo personale Studio Ghiglione, Genova, febbraio 1987
Periodicamente mi incontro con Claudio Verna, ormai da moltissimi anni, e il mio compito diventa a un tempo più facile e più difficile, giacché l’artista e il crìtico s’intendono con empatetica immediatezza quasi su tutto mentre i margini di parola si fanno più stretti. Meglio far parlare, allora, direttamente l’artista, tentare una costruzione del discorso critico attraversando i suoi pensieri e le sue parole. Nel suo studio mi sfilano dinanzi i quadri degli ultimi anni, che Verna stacca dalle pareti e li mostra con un ritmo giusto, né troppo lento né troppo veloce, accompagnando i gesti con poche parole di commento, una indicazione tematica, una data, qualche sottolineatura di ordine linguistico, una associazione con opere più remote che un segno o una stesura di colore fanno improvvisamente riafforare alla memoria.
Mi colpisce la sprezzatura pittorica, la forza, quasi la violenza gestuale dei quadri più recenti. Soprattutto uno mi prende di contropiede: «La notte di S. Silvestre», un titolo puramente occasionale eppure singolarmente emblematico della chiusura di un ciclo, di un passaggio e di un cambiamento. «Nel dipingere queste opere – mi dice Verna – riaffiorano delle asprezze, delle inquietudini». E aggiunge: «L’inquietudine nasce dal rischio della Bellezza». Trascrivo così il termine, impiegando l’iniziale maiuscola e il corsivo, in quanto colgo nella sua voce una intenzione, una sottolineatura particolare.
Verna ha paura della Bellezza? Mettendo, per così dire, tra virgolette il termine con una lieve inflessione della voce, Verna mi sta dicendo che la bellezza reca con sé un rischio, di essere anche troppo accattivante e gradevole. In fondo l’artista guarda con un certo sospetto alla sua stessa abilità, alla sua scaltrezza formale, che può anche prendergli la mano e portarlo velocemente in un luogo non propriamente voluto, desiderato. Di qui la sua ricerca recente della dissonanza, quasi della sgradevolezza.
Non è la prima volta, del resto, che Verna mette in discussione il quadro riaffermando i diritti della pittura. Un tema, quasi un leitmotiv, che ci accomuna in maniera stretta, che attraversa l’intero arco del nostro lavoro, di pittore e di critico. Un tema, una questione, ancora di grandissima attualità dopo che il rinascimento pittorico postmoderno si è rapidamente trasformato in una pratica disinvolta, preoccupata soprattutto di coprire la superficie con non importa che cosa pur di finire il quadro nei modi più giusti, ossia più disponibili alle nuove aspettative. Per Verna il difficile consiste nel «fare la pittura, non nel fare il quadro» e questo vuoi dire che nella sua opera, anche in quella di questi ultimi anni certamente più «libera» e veloce, persiste sempre una «memoria analitica». Per quel che mi riguarda, si tratta di una distinzione che porto con me da moltissimi anni, forse fin da quando ho cominciato questo singolare mestiere che è la critica, e che ha orientato non poche delle mie scelte.
Credo che per questo motivo, provo una sensazione di impazienza di fronte alle letture dell’opera di Verna tendenti a dividerne il percorso in due momenti separati – il momento analitico e quello espressivo – e a privilegiarne uno dei due, il secondo con più frequenza, quasi che (l’ho già scritto una volta, ma voglio ribadirlo) mettere in libera uscita le proprie pulsioni sia di per sé una garanzia maggiore di riuscita estetica rispetto alla messa in atto di procedimenti più marcatamente mentali. «Fare la pittura, non fare il quadro»: Verna enuncia questa proposizione a bassa voce, quasi a se stesso, forse per dirmi che si tratta di un dato per noi anche troppo evidente e che, tutt’al più, occorre ribadirne il senso per gli altri.
Altri critici? Altri artisti? Non ho il coraggio (l’improntitudine) di chiederglielo, ma gli ricordo (per una associazione di pensieri) che la sua mostra personale, qui a Genova, viene subito dopo una esposizione come l’«Astrazione povera» da me pensata e realizzata proprio sulla base di una idea critica che vuole mettere in evidenza quelle pratiche pittoriche che non coprono e nascondono la pittura, ma ne mettono in evidenza i dati costitutivi attraverso un processo combinato di riduzione-costruzione. Inutile dire che conosce bene il lavoro di questi artisti, da quell’instancabile e scrupolosissimo osservatore dell’arte quale egli è. Soprattutto per quanto riguarda l’arte dei più giovani.
«Non ho ancora messo i paletti intorno al mio campo. Piccolo o grande che sia. Ogni momento, per me, è ancora un’avventura. Mi sento sempre in tensione». Verna vìve in bilico tra sollecitazioni opposte, tra l’attrazione e, direi, la vertigine, della sua storia, che lo riporta continuamente alle sue radici e cerca di ancorare alla immagine di artista ormai affermato e riconosciuto; e la suggestione fortissima che il presente esercita su di lui e che egli vive anzitutto nel suo quotidiano corpo a corpo con la pittura, la sua pittura, ma anche con l’incontro, appassionatamente cercato, con gli altri, con i più giovani soprattutto. «Sì, mi interessa questo tipo di astrazione. Ne apprezzo in particolare l’esigenza di riduzione, il bisogno di ricominciare da capo, di azzeramento linguistico». Del resto, proprio questo è stato il suo problema, alla fine degli anni cinquanta. E forse è questo il suo problema di oggi, questo il varco che egli ha saputo attraversare nella sua emblematica «Notte di S. Silvestre».
Ma anche nella seconda metà degli anni settanta, quando ha cominciato a muovere maggiormente la superfìcie pittorica, ad attraversarla non più con la continuità della stesura cromatica ma con le linee andamentali tracciate dal segno e rinsaldate dai flussi del colore, anche in quella occasione, Verna ha compiuto un azzeramento linguistico, ricominciando da una scomposizione della continuità del gesto nei suoi elementi costitutivi. Osservo, in proposito, che lo spostamento di accento della sua pittura, da una dominante analitica a una espressiva, si verifica proprio attraverso una liberazione della mano; e lui mi guarda sorpreso, quasi gli avessi carpito un segreto, una «ricetta» di laboratorio tenuta accuratamente nascosta. Poi mi fa vedere una serie di pastelli, in cui quella mia osservazione trova una eloquente conferma, e chiarisce l’intera questione con la sua consueta lucidità critica: «II 1977 è un anno che ho dedicato a una serie di pastelli in cui ho sperimentato le possibilità del gesto, disarticolandone il movimento continuo nei suoi elementi, nella componente del braccio, del polso, della mano, delle dita, persino». Ancora un passaggio, un varco stretto dunque, e solo dopo viene l’esplorazione libera della pittura, dell’infinito delle sue possibilità.
La mostra genovese è imperniata su questa fase del lavoro artistico di Verna che sì estende, ormai, per circa una diecina d’anni. Il procedimento pittorico sembra andare incontro a una accelerazione e a un riscaldamento e l’opera che ne risulta si identifica sempre con la superficie, ma questa subisce un processo di ispessimento, di addensamento materico in modo di ospitare al proprio interno una più ricca serie di eventi pittorici. Su questo aspetto del suo lavoro Verna è rimasto colpito da quel che ne ha scritto di recente Elena Pontiggia nel catalogo della mostra milanese «Geografie oltre l’Informale». Trovo anch’io particolarmente felice questo testo, soprattutto nel punto in cui viene ricordata una frase di Nicolas De Staci, un artista molto amato da Verna: «Lo spazio della pittura è un muro, ma tutti gli uccelli del mondo vi volano dentro». E’ ciò che accade nell’opera di Verna, dove non c’è profondità prospettica e lo spazio è bidimensionale come un muro: «Ma infinita, e ansiosa è l’animazione che lo agita, i segni e i voli che lo attraversano».
Torna alla mente l’inquietudine della «Notte di S. Silvestre» e mi spinge a saperne di più, ad affondare maggiormente nell’universo poetico dell’artista. Gli chiedo notizie dei suoi «maestri», degli angeli custodi e numi tutelari e «fantasmi» che con più assiduita hanno accompagnato e lo accompagnano nel suo voro quotidiano. Sullo sfondo campeggia la fìgura di Matisse, ma la sua è una presenza così certa, così assoluta, da apparire scontata. Quasi non mette conto parlarne. Meglio cogliere di sorpresa l’interlocutore pronunziando i nomi di Gorky e di Twombly.
«Sì, questi artisti mi interessano perché nella loro opera trovo un forte aggancio con il reale, vi sento la presenza dell’uomo e delle cose». La loro pittura, così perfetta nella sua risoluzione formale e nello stesso tempo così profondamente radicata alle ragioni esistenziali, pulsionali del soggetto, è un esempio eloquente di come si possa evitare l’«arbitrio» e il «gratuito»; di come l’arte possa cercare e attingere un «affondo nella realtà». Soprattutto se non ci introduce soltanto nei luoghi accoglienti della Bellezza ma si dispone ad accogliere l’inquietudine del terrain vague e dell’ignoto.

